Betocchi, l'anticonformista dimenticato
Se tanta poesia del Novecento ha esaltato il dubbio e l’insicurezza in cui l’uomo è immerso, specchio del relativismo dell’epoca, Carlo Betocchi ha espresso nei suoi versi la certezza che considerarsi padroni del proprio destino è un'illusione.
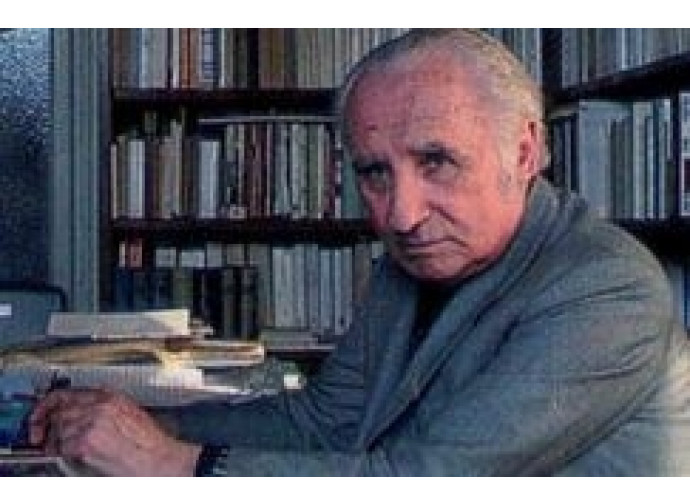
Bisogna ripercorrere almeno le linee salienti della vita di questo poeta che è stato ingiustamente dimenticato, pressoché assente da tutte le antologie scolastiche, pur essendo, a nostro avviso, uno dei grandi del Novecento.
Nato a Torino nel 1899, Carlo Betocchi intraprende quel percorso di studi così inconsueto per un letterato, eppure così abituale per i poeti del Novecento, che è caratterizzato da un’impostazione tecnica e professionale. Infatti, trasferitosi a Firenze e perso il padre a soli dodici anni, si diploma geometra. Appartiene alla generazione del ’99, quella che parte per la guerra a soli diciotto anni. Molti vengono chiamati alle armi nel 1917 e, dopo essere stati frettolosamente istruiti, sono inviati a combattere. Non si sa quanti perdono la vita tra le centinaia di migliaia di ragazzi che partono. Ufficiale al fronte, Carlo Betocchi appartiene al novero di quanti fanno ritorno dalla guerra. Solo dopo il 1928 è di nuovo a Firenze, città in cui vive il decennio per eccellenza dell’Ermetismo fiorentino e attraversa l’esperienza della rivista cattolica «Il Frontespizio», che dal 1929 al 1940 cercherà di recuperare una visione religiosa della letteratura, contrapponendosi all’ondata culturale dominante del decennio. La prima raccolta Realtà vince il sogno (1932) è seguita nell’ordine da Altre poesie (1939), Notizie di prosa e poesia (1947), Un ponte sulla pianura (1953), Poesie (1955), L'estate di San Martino (1961), Un passo, un altro passo (1967), Prime e ultimissime (1974), Poesie del sabato (1980). Betocchi morirà a Bordighera nel 1985.
«Betocchi appartiene» scrive Sauro Albisani «a una specie molto più rara di quella del poeta: è un animale religioso. Soprattutto: un autentico animale religioso» (Sauro Albisani). In realtà, ogni uomo è, in primo luogo, un homo religiosus, ovvero un essere che si pone domande sulla vita, sul senso e sul destino del tutto, come il pastore errante dell’Asia di leopardiana memoria che si chiede: «Che fai tu Luna in ciel? […] A che vale/ Al pastor la sua vita,/ La vostra vita a voi? Dimmi; ove tende/ Questo vagar mio breve,/Il tuo corso immortale?». Eppure, la considerazione dell’Albisani ci conferma che l’uomo oggi si comporta come se fosse soprattutto homo oeconomicus, un essere che ha sostituito il desiderio del cuore con una molteplicità di bisogni materiali da soddisfare. Così, Betocchi «ha l’aria del bambino capitato per caso in mezzo a gente con la quale non ha niente da spartire». Egli è, per così dire, «poeta per sbaglio» e «la poesia è un mezzo, […] una pratica religiosa» (S. Albisani). Proprio nel recupero di questa dimensione religiosa dell’esistenza fondamentali nella sua vita sono gli amici, ad esempio quelli con cui collabora nella rivista di cui sopra si è parlato (Piero Bargellini, Carlo Bo, Mario Luzi), e la madre che sarà per lui un costante punto di riferimento per la sua fede, come accade per Ungaretti.
In questa trama di rapporti Betocchi si accorge che ciò che manca maggiormente nella società contemporanea è un io e scopre che proprio l’io è l’essenziale bisogno oggi, concetto che è ben espresso nella poesia «Ciò che occorre è un uomo». Il testo recita così: «Ciò che occorre è un uomo/non occorre la saggezza,/ciò che occorre è un uomo in spirito e verità;/non un paese, non le cose/ciò che occorre è un uomo/un passo sicuro/e tanto salda la mano che porge,/che tutti possano afferrarla/e camminare liberi e salvarsi». L’uomo ha necessità di riscoprire che il primo fondamento per vivere, per muoversi, per resistere alle intemperie della vita in cui sembra di essere sommersi dalle circostanze è l’io. L’uomo avverte che il proprio cuore anela ad un’acqua viva e zampillante in eterno, di una felicità infinita. L’animo umano è presentato nei termini evangelici e, al contempo, leopardiani. Solo la constatazione di trovarsi in un arido deserto (Dante lo rappresentava come una selva oscura) può permettere all’uomo di domandare e di mendicare, di chiedere aiuto e accettare la mano che gli permette di rialzarsi.
Nella poesia «Della solitudine» sentiamo come Betocchi sappia cogliere l’essenziale valore dell’attraversamento della circostanza e della condizione umana di solitudine: «Io non ho bisogno/che di te, solitudine;/alta, solenne, immortale,/dove più nulla è sogno.//In questo deserto/ attendo l’implacabile/ venuta d’un’acqua viva/ perché mi faccia a me certo». Se tanta poesia del Novecento ha esaltato il dubbio e l’insicurezza in cui l’uomo è immerso, specchio di quel crollo delle certezze e di quel relativismo che caratterizza l’epoca, Betocchi si stupisce di fronte alla prima evidenza, cioè quella che la realtà c’è: «E godo la terra/bruna, e l’indistruttibile/certezza delle sue cose/già nel mio cuore si serra://e intendo che vita/è questa, e profondissima/luce irraggio sotto i cieli/colmi di pietà infinita». Non c’è presunzione nei suoi versi, non c’è una vantata superiorità intellettuale, ma, al contrario, emerge quella percezione esistenziale che dovrebbe accomunare ogni uomo, quel senso di sproporzione tra la propria pochezza e miseria e l’anelito di verità totale a cui il nostro cuore aspira.
Betocchi così scrive nella poesia «Come tutti» che ha salito «le scale del […] non sapere» senza avere «parola che dicesse il possibile/ (entro il credibile, entro quel che è da credere,/ e non è mio, è di tutti)». Eppure, nel tempo, si è fatto «uno che parla a stormi di versi/affamati di verità, come passeri nel gelo/d'inverno». Betocchi è come un povero di spirito di evangelica memoria, «come tutti i beati poveri, tutti/i santi beati che hanno lasciato se stessi/per trovar l'Altro, il vero, il solo sapiente». Il tempo, passando, consuma le forze e le energie, ma, nonostante ciò, in lui «l’amore […] resiste/ ed è esigente» (dalla poesia «Quasi ubriaco»). Nonostante non rimanga altro «che lo stento di una vita/ che sta passando, e perduto il suo fiore/mette spine e non foglie, e a malapena/respira», rimane in Betocchi «quell’amore nascosto […],/quel sentore di terra, che resiste,/come nei campi spogli: una ricchezza/creata, […] inestinguibile». Anche nella vecchiaia, quando «la vita che rallenta/si riveste di una grossa corteccia/entro la quale l'anima è non meno/tenera, ma soltanto più solitaria», anche allora quando i sensi sono attenuati e, talvolta, quasi spenti «la vita sente e ripensa se stessa/con i medesimi palpiti» (dalla poesia «A questa età»).
Nella stessa prospettiva, se san Francesco apostrofa la morte come «sorella» nel «Cantico delle creature», Betocchi parla di «amata morte», non già perché desideri che tutto finisca, che la sofferenza e il dolore finalmente abbandonino le sue giornate, non già perché la morte sia la «fatal quiete» per dirla col Foscolo, bensì perché «un’altra […] vita risorge,/ nulla finisce, anzi tutto continua, o morte,/ o amata morte, o amata» (da «Qui e ora»). Certamente, Betocchi non dimentica la croce, «l’amarezza dell’abbandono» (da «A mani giunte»), non si scorda che gli uomini vivono l’illusione «di viver padroni dell’essere proprio» (da «Condizione»). La vera religiosità è riconoscere l’originaria dipendenza dall’Essere che mi ha fatto, che mi fa in ogni istante e verso cui tendiamo. Solo questa certezza incrollabile incontrata nell’esistenza può far amare all’uomo il proprio destino, vagheggiandolo come il punto dell’incontro finale.

